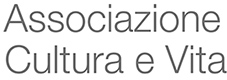Bellezza tardo antica medioevale
a.a. 2015/2016
CORSO “LA BELLEZZA: ASPETTI IN ETÀ TARDOANTICA E MEDIEVALE”
diretto dalla Prof. Roberta Budriesi, Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna
Martedì 24 maggio 2016 alle ore 16
presso l' Aula Magna dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
di Modena, Corso Vittorio Emanuele II, n° 59, Modena
si terrà la settima lezione del Corso.
Interverrà
il prof. CESARINO RUINI
professore ordinario di Storia della Musica medievale e rinascimentale
e Paleografia musicale nella Scuola di Lettere e Beni culturali
Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna
su:
"L'ORIZZONTE ESTETICO DELLA MUSICA MEDIEVALE"
La S.V. Ill.ma è invitata.
prof. Maria Teresa Camurri
Presidente Cultura e Vita
www.culturaevita.unimore.it
La comprensione delle opere musicali del passato è resa tanto più
difficile quanto più esse sono distanti da noi nel tempo. Anche se
l’ambito di riferimento rimane la tradizione colta occidentale, ogni
tentativo di ridare vita alle note conservate negli antichi documenti
musicali passa necessariamente attraverso la sensibilità dell’interprete,
le aspettative dell’ascoltatore e l’orizzonte culturale di entrambi. In
effetti è impossibile per noi oggi sia ricostruire l’immaginario
collettivo sia conoscere le molteplici sfumature esecutive trasmesse
oralmente di maestro in allievo, che erano parte della vita quotidiana e
della formazione del pubblico e musicisti di tanti secoli fa. Ciò comporta
che lo stesso repertorio gregoriano, nel quale è custodito il patrimonio
genetico della nostra attuale musica d’arte, produca all’ascolto un
effetto estetico di esotismo e possa essere stravolto fino al suo impiego
come sottofondo di atmosfere erotiche. Ma le stesse considerazioni
potrebbero estendersi con buona approssimazione a tutta la polifonia
rinascimentale!
Tuttavia, tale patrimonio musicale, attraverso il quale passa tanta parte
della nostra identità culturale, può riacquistare senso ed esplicare tutto
il suo potenziale comunicativo e suggestivo, se contestualizzato,
ricostruendo idealmente gli edifici, gli scopi, gli ambiti e gli usi
sociali per i quali fu concepito ed eseguito. È un percorso che si snoda
innanzitutto attraverso la piena comprensione dei testi letterari sui
quali le musiche vennero composte (non a caso si tratta sempre di musica
vocale, a volte con accompagnamento strumentale), ma deve ricavare tutte
le informazioni possibili dallo studio della liturgia, delle consuetudini
sociali, dell’iconografia musicale, dell’architettura dei luoghi di culto
e di spettacolo, oltre che del pensiero filosofico e teologico.
Solo in questo modo è possibile colmare la distanza estetica che ci fa
sembrare tutte uguali le melopee gregoriane, sia che intonino testi di
mestizia e dolore sia che rivestano parole di gioia ed esultanza (i
sentimenti umani, sublimati nella esperienza mistica del divino e
dell’eterno, perdono i connotati che ci sono più usuali!), oppure dare un
senso al mottetto Nuper rosarum flores, composto da Guillaume Dufay per la
consacrazione del duomo di Firenze dopo il completamento della cupola del
Brunelleschi: il brano ripropone nella sua partizione interna le
proporzioni del Tempio di Salomone, modello di ogni chiesa. Però
l’ascoltatore (e anche l’esecutore non informato) di questa artificiosa
architettura musicale non percepirebbe nulla, se si affidasse al solo
ascolto, fosse anche della più raffinata esecuzione.